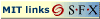Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/6595| Title: | Aenigmatica varietas. Il paradosso come forma del filosofare fra Quattrocento e Cinquecento |
| Authors: | D'Onofrio, Giulio Cambi, Maurizio Huẞ, Bernhard Migliorini, Arianna |
| Keywords: | Paradosso;Umanesimo;Retorica |
| Issue Date: | 20-Jul-2021 |
| Abstract: | La mia tesi si propone di indagare le implicazioni teoretiche del ricorso al dispositivo concettuale del
paradosso in una selezione di autori quattro-cinquecenteschi: Leon Battista Alberti, Giovanni Pico
della Mirandola, Erasmo da Rotterdam e Ortensio Lando. Il dato storico dal quale la ricerca prende
le mosse riguarda l’elevata incidenza di opere paradossali che videro la luce nei secoli in oggetto,
ispirate, per la maggior parte, dalla fortunata riscoperta dell’antico genere sofistico dei
ἐγκώ ι e dall’accentuata ammirazione degli umanisti per lo stile serio-ludico di Luciano di
Samosata. A partire da un’analisi della ricezione quattro-cinquecentesca di questo peculiare artificio
retorico, il lavoro si propone di indagare se e come quest’ultimo abbia potuto travalicare la mera
dimensione dell’exercitatio ludica, rivestendosi di specifiche connotazioni polemiche, eversive o
euristiche legate alle potenzialità teoretiche che contraddistinguono il concetto stesso di paradosso.
Dall’analisi condotta emerge quanto frequente, capillare e diversificato fosse il ricorso al paradosso
nelle opere prese in esame e viene evidenziato il valore filosofico di un dispositivo concettuale in
grado di dischiudere una via di accesso alla verità attraverso lo smascheramento della menzogna, la
messa in discussione della doxa, lo stimolo nella prosecuzione della ricerca e il vaglio di alternative
situate al di fuori delle logiche convenzionali. [a cura dell'Autore] My thesis is focused on assessing the theoretical value of paradox in Renaissance philosophy, starting from the analysis of Latin and vernacular texts composed by Leon Battista Alberti, Giovanni Pico della Mirandola, Erasmo da Rotterdam and Ortensio Lando. The research is historically justified by the wide dissemination of paradoxical works in the XV and XVI centuries, due to the fortunate rediscovery of the ancient sophistical genre of ἐγκώι and to the high consideration humanists had for Luciano of Samosata’s playful, and yet edifying, writing-style. The purpose of the thesis is then to investigate whether such paradoxical works could represent something deeper than a simple jeu d’esprit, assuming subversive or defiant meanings as the very concept of paradox may lead to suggest. The results of the analysis point out how varied and widespread the use of paradox was in the Renaissance, employed as a conceptual tool able to allow philosophical reflection through unconventional channels, such as the uncovering of falsehood and the critical question of common opinion. [edited by Author] |
| Description: | 2019 - 2020 |
| URI: | http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/6595 http://dx.doi.org/10.14273/unisa-4660 |
| Appears in Collections: | Ricerche e Studi sull’Antichità, il Medioevo e l’Umanesimo, Salerno (RAMUS) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| tesi_di_dottorato_A_Migliorini.pdf | tesi di dottorato | 2.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
| abstract in italiano e in inglese A. Migliorini.pdf | abstract a cura dell’autore (versione italiana e inglese) | 280.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
| tesi - frontespizio A. Migliorini.pdf | tesi di dottorato - frontespizio | 370.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.